Il linguista Tullio De Mauro sottolinea i problemi che una situazione culturale così devastante comporta per la democrazia in questo paese: sette italiani su dieci non sono semplicemente in grado di capire cosa viene loro detto e spiegato dagli organi di informazione, anche nel caso che questi facciano realmente – e accade di rado – un buon servizio.
In un periodo storico in cui al cittadino medio viene chiesto di votare su argomenti complessi, che richiederebbero un approfondimento notevole e una buona dose di senso critico per vagliare la reale portata e le implicazioni delle proposte dei vari partiti, il 70% degli Italiani non capisce, molto banalmente, nemmeno di che cosa si stia
parlando.
Uscire da una situazione così tragica però è un problema arduo. Non è soltanto trovare i fondi per la digitalizzazione della scuola, o fare proposte bizzarre per costringere gli insegnanti a fare più ore di lezioni: significa che bisogna ripensare dalle fondamenta il sistema della istruzione e della formazione. Perché sette italiani su dieci che non sanno in pratica leggere non sono un problema culturale. Sono un problema politico ed economico. Per tutti.
Sono tre brani di un articolo interessante ma molto deprimente sulla questione del...rimborso dell'IMU. A parte il ruolo della scuola, io credo che molta responsabilità sia degli organi informativi. Il maestro Manzi insegnava a leggere e scrivere, ad "operare" con i singoli dati (mettere insieme le lettere dell'alfabeto); per far questo bastava e avanzava la televisione. Ora servirebbe insegnare come si mettono insieme i dati per avere informazione e acquisire conoscenza; per far questo, di mezzi, ce ne sono fin troppi: non soltanto la TV, evidentemente. Tra i sette saperi necessari all'educazione del futuro, Edgar Morin ha messo la conoscenza pertinente: nelle scuole si può sensibilizzare quanto si vuole e cercare di creare un idoneo substrato culturale, ma se poi il panorama informativo è povero, c'è poco da fare!
Ecco perchè il ruolo dei giornalisti è fondamentale. Parlo dei (ai) giornalisti, perchè degli editori non mi fido. Non mi fido perchè chiedono l'intervento pubblico del prossimo Governo "sul fronte della domanda - circoscritto nel tempo e ben delineato nell’oggetto – è indispensabile per superare l’emergenza e tutelare davvero il pluralismo: ad esempio nella forma di incentivi fiscali per favorire la ripresa degli investimenti pubblicitari e per diffondere la lettura dei giornali tra i giovani" (via) senza porsi minimamente il problema del ruolo che svolgono nella società. Faccio un paio di esempi: (1) la pubblicazione di uno sconcertante appello al voto delle donne del PDL (in cui sono stati utilizzati dei volti evidentemente inconsapevoli) sul Corriere; (2) l'ipocrita indignazione di Repubblica all'ennesima inqualificabile esternazione di Berlusconi: come sacrificare la funzione sociale sull'altare della mera monetizzazione.
Parlo dei (e ai) giornalisti, quindi. C'è bisogno di un ruolo di guida, complementare agli insegnamenti della scuola: l'informazione e la conoscenza è nelle vostre mani!
Un Governo serio, quindi, è a loro che dovrebbe direttamente concedere i contributi pubblici per l'editoria sotto forma di Reddito Minimo Garantito. Questa la proposta, assolutamente plausibile, fatta Jacques Rosselin sull'Huffington Post Francia (via). A mio avviso, anche per rispondere al commento all'articolo originale segnalato da LSDI ("Poiché è assurda la distribuzione a fondo perduto di 1,6 miliardi di euro a organi di informazione mantenuti in vita attraverso la respirazione artificiale (anche quando sono portavoce di gruppi finanziariamente solidi), la proposta è lungi dall’ essere insensata.
Anche se sarebbe complicato trovare delle modalità di applicazione semplici."), il modo per farlo c'è: sarebbe sufficiente far transitare i contributi pubblici per le mani dei cittadini, delegando a loro la scelta dell'articolo (in un set ristretto solo agli articoli di qualità, cioè funzionali alla crescita). Il Modello Fotovoltaico non è altro che questo.
Immagine Pigazzetta
Visualizzazione dei post in ordine di pertinenza per la query i sette saperi. Ordina per data Mostra tutti i post
Visualizzazione dei post in ordine di pertinenza per la query i sette saperi. Ordina per data Mostra tutti i post
domenica 24 febbraio 2013
domenica 29 maggio 2011
da Modello di Business a Modello Sociale?
Ritengo il ruolo del Giornalismo di vitale importanza per il progresso della Società delle Persone, di quello che negli ultimi tempi ho voluto definire ecosistema-Stato. Il Modello WIKiD è solo uno strumento che riesce a formalizzare meglio il pensiero, la teoria sulla quale poi dovrebbe poggiare una pratica.
Nel mio spazio ho rivolto da più di un anno la mia attenzione al Giornalismo e all'Editoria, stimolato dalle parole di tanti esperti e dalle azioni/esperimenti (da tali esperti segnalate nei rispettivi spazi) dei player sulla via della ricerca del miglior Modello di Business per l'Editoria stessa.
La questione, nel mio percorso di studi, ha via via preso dei contorni più ampi: la mia analisi, concentrata in principio esclusivamente sul Business, si è allargata alla Società, alle Persone, agli agenti (per usare un termine caro alla sociologia) o (per usarne un altro) a tutti i portatori di interesse.
Non solo gli Editori quindi, ma anche e soprattutto le Persone e lo Stato come stakeholder; non solo il fatturato ma anche e soprattutto, la crescita della società, dell'ecosistema-Stato come obiettivo.
Il Modello-Fotovoltaico, che ha riassunto [insieme con la definizione di qualità nello spazio tridimensionale dei contenuti] alcune delle conclusioni alle quali sono giunto, non credo sia "automaticamente" sostenibile in una società come la nostra per questioni di cultura e di educazione. Non mi riferisco [soltanto] all'aspetto puramente tecnologico ma, principalmente, alla congenita e generale limitatezza delle nostre attitudini ad analizzare e ad essere curiosi, a contestualizzare i fatti, a sviscerarli; e alla nostra più naturale propensione alla delega, al superficiale, alla velocità.
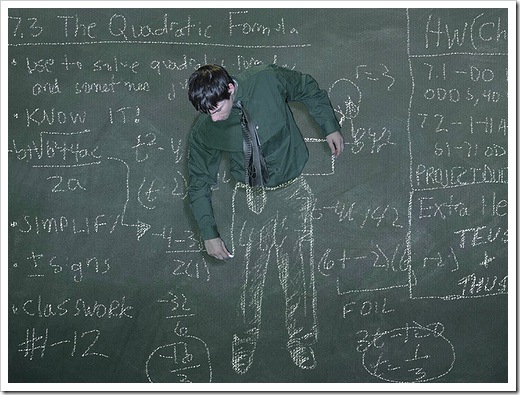
Ho invaso numerosi campi che i miei studi da Ingegnere non mi avrebbero dovuto autorizzare ad invadere; questa è la ragione per cui, sebbene sia forte l'idea che tanto dovrebbe farsi nelle scuole, non potendo argomentare come vorrei, non posso far altro che segnalarvi il saggio del sociologo Edgar Morin, "I sette saperi necessari all'educazione del futuro".
Mentre ne leggevo le tesi non ho potuto fare a meno di riflettere sul fatto (credo anche scontato) che la creazione di una nuova cultura nelle scuole non può non accompagnarsi ad una serie di azioni che ne possano permettere la pratica. Identificando ancora nello Stato l'ente responsabile, torniamo al punto di partenza: l'obiettivo è la crescita della Società, l'aumento del suo benessere con un contestuale (visto sia come causa sia come effetto) aumento del Capitale Sociale. [Il Modello WIKiD parla di Saggezza].
Cosa, se non il contenuto di qualità (inteso come quello della zona rossa del modello 3D), può avviare le Persone alla creazione di [educazione a] quella che Morin definisce conoscenza pertinente, intesa come la conoscenza che riesce a contestualizzare il suo oggetto (mettendolo anche in relazione con altri oggetti)?
E cosa, poi, se non il contenuto di qualità distribuito dagli Editori, può agevolare le Persone ad interpretare la realtà fornendo strumenti per affrontare l'inevitabile incertezza rispetto al futuro (e a questo Morin dedica un intero capitolo)? Pascale e Rastello, nel loro breve scritto "Democrazia: cosa può fare uno scrittore?" criticano aspramente il Sapere Nostalgico e la Retorica dell'Apocalisse utilizzata da molti scrittori e giornalisti per affermare l'ovvio in una piattezza che vuole semplicemente non turbare un target (i lettori) che, così, non viene aiutato a vivisezionare la conoscenza [per usare il WIKiD - a non progredire verso la Saggezza].
Cosa, infine, se non anche la connessione digitale tra le persone e, quindi, anche tra i popoli di Nazioni e/o Culture e/o Religioni e/o Società diverse (e dei rispettivi patrimoni di conoscenza), può stimolare la reciproca comprensione, la comunicazione, l'interdisciplina e affermare le diversità (altri temi, questi, ricorrenti nelle pagine del sociologo francese)?
E' difficile, da questa ulteriore prospettiva, fare delle conclusioni sulla questione dell'Editoria; richiederebbe senza dubbio altre letture. Questo saggio però, per ora, mi è bastato per trovare delle basi pedagogiche ad un Modello che, più che di Business, comincerei a chiamare Sociale (è presunzione?).
I commenti sono a vostra disposizione!
Aggiornamento del 18 Giugno 2011: embed di una discussione su un articolo del Giornalaio
Nel mio spazio ho rivolto da più di un anno la mia attenzione al Giornalismo e all'Editoria, stimolato dalle parole di tanti esperti e dalle azioni/esperimenti (da tali esperti segnalate nei rispettivi spazi) dei player sulla via della ricerca del miglior Modello di Business per l'Editoria stessa.
La questione, nel mio percorso di studi, ha via via preso dei contorni più ampi: la mia analisi, concentrata in principio esclusivamente sul Business, si è allargata alla Società, alle Persone, agli agenti (per usare un termine caro alla sociologia) o (per usarne un altro) a tutti i portatori di interesse.
Non solo gli Editori quindi, ma anche e soprattutto le Persone e lo Stato come stakeholder; non solo il fatturato ma anche e soprattutto, la crescita della società, dell'ecosistema-Stato come obiettivo.
Il Modello-Fotovoltaico, che ha riassunto [insieme con la definizione di qualità nello spazio tridimensionale dei contenuti] alcune delle conclusioni alle quali sono giunto, non credo sia "automaticamente" sostenibile in una società come la nostra per questioni di cultura e di educazione. Non mi riferisco [soltanto] all'aspetto puramente tecnologico ma, principalmente, alla congenita e generale limitatezza delle nostre attitudini ad analizzare e ad essere curiosi, a contestualizzare i fatti, a sviscerarli; e alla nostra più naturale propensione alla delega, al superficiale, alla velocità.
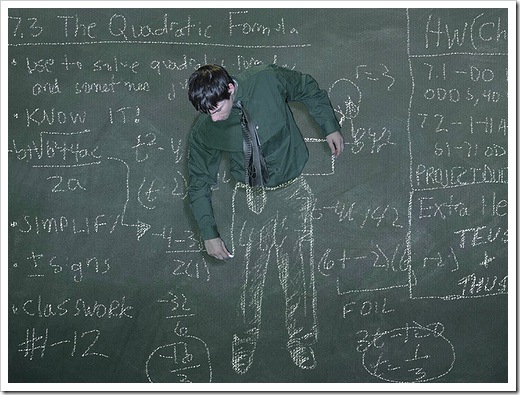
Ho invaso numerosi campi che i miei studi da Ingegnere non mi avrebbero dovuto autorizzare ad invadere; questa è la ragione per cui, sebbene sia forte l'idea che tanto dovrebbe farsi nelle scuole, non potendo argomentare come vorrei, non posso far altro che segnalarvi il saggio del sociologo Edgar Morin, "I sette saperi necessari all'educazione del futuro".
Mentre ne leggevo le tesi non ho potuto fare a meno di riflettere sul fatto (credo anche scontato) che la creazione di una nuova cultura nelle scuole non può non accompagnarsi ad una serie di azioni che ne possano permettere la pratica. Identificando ancora nello Stato l'ente responsabile, torniamo al punto di partenza: l'obiettivo è la crescita della Società, l'aumento del suo benessere con un contestuale (visto sia come causa sia come effetto) aumento del Capitale Sociale. [Il Modello WIKiD parla di Saggezza].
Cosa, se non il contenuto di qualità (inteso come quello della zona rossa del modello 3D), può avviare le Persone alla creazione di [educazione a] quella che Morin definisce conoscenza pertinente, intesa come la conoscenza che riesce a contestualizzare il suo oggetto (mettendolo anche in relazione con altri oggetti)?
E cosa, poi, se non il contenuto di qualità distribuito dagli Editori, può agevolare le Persone ad interpretare la realtà fornendo strumenti per affrontare l'inevitabile incertezza rispetto al futuro (e a questo Morin dedica un intero capitolo)? Pascale e Rastello, nel loro breve scritto "Democrazia: cosa può fare uno scrittore?" criticano aspramente il Sapere Nostalgico e la Retorica dell'Apocalisse utilizzata da molti scrittori e giornalisti per affermare l'ovvio in una piattezza che vuole semplicemente non turbare un target (i lettori) che, così, non viene aiutato a vivisezionare la conoscenza [per usare il WIKiD - a non progredire verso la Saggezza].
Cosa, infine, se non anche la connessione digitale tra le persone e, quindi, anche tra i popoli di Nazioni e/o Culture e/o Religioni e/o Società diverse (e dei rispettivi patrimoni di conoscenza), può stimolare la reciproca comprensione, la comunicazione, l'interdisciplina e affermare le diversità (altri temi, questi, ricorrenti nelle pagine del sociologo francese)?
E' difficile, da questa ulteriore prospettiva, fare delle conclusioni sulla questione dell'Editoria; richiederebbe senza dubbio altre letture. Questo saggio però, per ora, mi è bastato per trovare delle basi pedagogiche ad un Modello che, più che di Business, comincerei a chiamare Sociale (è presunzione?).
I commenti sono a vostra disposizione!
Aggiornamento del 18 Giugno 2011: embed di una discussione su un articolo del Giornalaio
Iscriviti a:
Post (Atom)
.jpg)